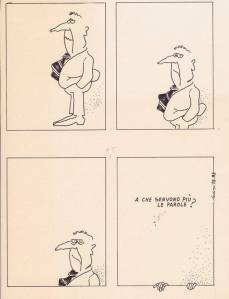L’urlo della sirena squarciò il silenzio lattiginoso dell’alba, riecheggiando nei cortili deserti, rimbalzando contro i vetri delle finestre, ostinatamente chiuse, dei palazzoni anonimi che si ergevano come bizzarri monconi diseguali ad ostruire l’orizzonte. Il cielo grigio restò immobile, sospeso sulle teste chine degli operai del turno di notte che marciavano come automi verso l’uscita. Una fila identica, in direzione opposta, veniva ingoiata, a passo cadenzato e lento, dalle fauci della POIESIS, sparendo dietro l’enorme portone di ferro che di lì a poco avrebbe imprigionato senza via di scampo i settecentotrentasei addetti al turno di giorno. Erano creature notturne e neglette, gli operai della POIESIS, avvolti in una divisa ormai scolorita, sul cui bavero un minuscolo triangolino colorato, contrassegnato da un numero progressivo, sanciva inequivocabilmente la mansione definitiva; millequattrocentosettantadue esseri umani costretti a non vedere mai, se non per qualche istante, la luce incerta del sole.
Il Ministero della Produzione Letteraria aveva imposto alla nazione uno sforzo sovrumano che richiedeva turni massacranti di 12 ore consecutive, senza possibilità di interruzione. Alla necessità di produrre 8732 tonnellate di letteratura al mese, di cui almeno 1746,4 di poesia, per una portata annua di 104784 tonnellate in totale, si aggiungeva l’aggravante della diminuzione inesorabile, ai limiti della carestia, di materiale utilizzabile per i nobili fini artistici. Prima fra tutte le concorrenti ad intuire possibilità di guadagno in un settore del mercato non ancora battuto, la POIESIS aveva quindi allargato il suo raggio d’azione affiancando alla ormai famosa macchina produttrice di versi e prose, chiamata PROSIMETRON, un poderoso impianto di raccolta di materiale completamente riciclabile e riutilizzabile con il minor danno possibile per l’ambiente letterario. Un centinaio di furgoni circolavano, giorno e notte, intenti a raccogliere qualsiasi oggetto avesse un’aria obsoleta, decadente, metaforica o metonimica; c’erano poi le idrovore, che di notte risucchiavano dalle fogne e dai canali di scolo, poesie e frasi vomitate da letterati in evidente condizione di alcolismo e depressione; infine migliaia di container colmi di ambizioni disilluse, frustrazioni, successi ed improvvise cadute di intellettuali che avevano vissuto la transizione dall’ibridismo ideologico del Governo Senza Capo né Coda degli anni duemila alla nuova era di consapevolezza che il Governo degli Illuminati a Led avrebbe mantenuto grazie alla proverbiale durata quasi eterna delle sue lampadine.
La discarica, o per meglio dire il centro di raccolta di materiale poetico CRMP, era collegato alla fabbrica da una galleria sotterranea a nastro trasportatore, che conduceva alla sala di smistamento di materiale poetico SSMP; solo dopo un’accurata cernita da parte delle Muse – era l’unico settore in cui erano impiegate esclusivamente donne – il materiale selezionato raggiungeva il biotrituratore letterario PROSIMETRON V2040, suddividendosi infine in due canali distinti, uno a sinistra per la Produzione Poetica e le sue sottocategorie (Versi Liberi, Obbligati, Poemi, Canzoni, Ballate, et cetera) e uno a destra per la Produzione Prosastica di Metratura Variabile. Grazie ad algoritmi di precisione e a sapienti giri di rotelle regolatrici di licenza poetica, intensità di pathos e libertà di metafora, operati dagli Addetti alle Rifiniture, gli oggetti di cui sopra si tramutavano in parole, frasi, capitoli, ottave, Opere Compiute. L’ultimo passaggio prima del libero mercato consisteva nell’ispezione censoria della Commissione Appetibilità. Ciascuna opera veniva analizzata al microscopio, privata di elementi superflui e contrari alla pubblica morale e confezionata in modo da attirare l’attenzione del compratore, spesso utilizzando artifici promozionali di bassa lega. L’Autore, figura mitologica osannata nei secoli precedenti, era ormai un misero feticcio, incapace di fornire il necessario quantitativo di letteratura richiesto dal Ministero della Produzione Letteraria e dunque sostituito da più efficienti macchinari adatti alla bisogna. Non erano scomparsi del tutto, tuttavia coltivavano ispirazioni velleitarie e individuali all’oscuro della collettività, in sotterranei silenziosi e impenetrabili, o in soffitte polverose e ricolme di oggetti inservibili, antico retaggio elitario, fantasma di una torre eburnea crollata miseramente negli studi televisivi, tra la pubblicità di un salame e l’ultima uscita del best seller dell’Editore BURP, unico sopravvissuto alla guerra per la conquista dell’egemonia assoluta.
Quella mattina si verificò uno strano incidente, nella SSMP. Un incidente che per poco non mise a rischio l’intera produzione giornaliera. L’addetta n.1432 di nome Luigina Loni raccontò a mensa, tra un morso al pane di segale e una cucchiaiata di zuppa di fave, di aver udito un rumore insolito provenire dal nastro trasportatore, come se un corpo estraneo ne ostacolasse l’irrefrenabile percorso. Mossa da un misto di prudenza e preoccupazione, si era addentrata nella galleria per controllare meglio. Era un’operazione alquanto pericolosa, non c’era molto margine di movimento e bastava poco per ritrovarsi biotriturati in un’autobiografia di Teo Manzerti, teorico dell’ebetudine al potere, o peggio ancora in qualche saggio sociologico di Veno Bruspa, con tanto di plastico in omaggio. Sembrava non ci fosse nulla di strano. Sul nastro in successione sfilavano calze a rete, una piuma d’oca, una collezione di pipe ancora odorose di tabacco, un fazzoletto di seta insanguinato, un fiore secco e sottile, una fotografia ingiallita, un trenino giocattolo, una pietra di fiume, un pennello da pittore ancora intriso di colori ad olio, un bicchiere sbreccato di vetro verde scuro, una fiala di laudano. Tutto normale, pensò tra sé, finirà tutto a sinistra, forse solo le calze a rete andranno ad adagiarsi su una vezzosa poltroncina in un romanzetto rosa da sala d’attesa di parrucchiere. Ma il rumore si sentiva ancora. Era quasi come un sibilo, come se un oggetto ignoto opponesse tutta la resistenza possibile prima di finire tra mille altri oggetti informi a dare forma ad una storia qualsiasi del peso minimo stabilito dall’azienda di 756 grammi. Luigina Loni proseguì la sua ispezione con maggiore accuratezza, seguendo la direzione del sibilo inconsueto, percepibile malgrado il rumore assordante degli ingranaggi in movimento. In una catasta di legna passata velocemente in rassegna e indirizzata al biotrituratore letterario c’era un pezzo diverso dagli altri, più grande, rugoso e contorto, che sembrava voler sfuggire alla cernita fatale: scivolava all’indietro, rovinando addosso agli altri ciocchi indifferenti, pronti ad essere impiegati nella costruzione di una nuova Pequod, modernizzata e destinata a naufragare a causa dello scontro con un iceberg nei mari del Nord, senza balene bianche ma con una melodrammatica strage di ricchi borghesi, ottimo ingrediente per una miniserie di successo della HBO. Il ciocco ribelle indietreggiava, producendo uno stridio così simile a un grido di aiuto e fu allora che Luigina lo riconobbe, come se quel pezzo di legno secolare, dalla forma irregolare e sgraziata, recasse un messaggio segreto destinato solo a lei. Le tornarono in mente gli anni dell’infanzia nelle campagne del suo paese, un lembo di terra bruciato dal sole e schiaffeggiato dal maestrale, un luogo in cui il vento salato penetrava fin sotto la pelle e la primavera sapeva di alghe e di schiuma di onde. Era un ciocco di ulivo secolare, sradicato e fatto miseramente a pezzi per essere trasformato in prodotto poetico idoneo alla pubblicazione BURP e alla vendita nei migliori supermercati della nazione. Appariva nudo, dimesso, pressoché irriconoscibile eppure quei solchi profondi, scavati nel legno, disegnavano un volto pietrificato nell’atto di urlare. Luigina Loni non ci pensò due volte e con cautela afferrò il pezzo di legno, sottraendolo al suo destino di morte. Onde evitare un deficit di produzione, benché irrisorio, sostituì il ciocco con l’equivalente materico di 4,75 chilogrammi – pescato tra scarti di magazzino, gambe di tavoli e volantini pubblicitari: certo qualche caduta di stile ci sarebbe stata nelle Opere In Fieri, ma se ne sarebbero accorti in pochi. Era l’epoca della Quantità, la Qualità non aveva più grande importanza. A fine turno, Luigina tornò a casa con il suo prezioso bottino, euforica e spaventata al tempo stesso. Sotto la finestra del palazzone in cui abitava, al quarto piano senza ascensore, da una crepa dell’asfalto irrorata dalle piogge autunnali, era emersa una zolla di terra nera e umida, unico sprazzo di vita nella monotonia cementizia della periferia della città. Fu lì che decise di piantare il ciocco, senza grandi speranze in verità, in parte a causa del suo pollice verso, in parte rassegnata ormai a una vita priva di bellezza. Per diversi anni nulla accadde, malgrado Luigina si affacciasse ogni giorno alla finestra per controllare. La crepa era lì, la terra nera anche. Spesso i cani si divertivano a scavare, i bambini dopo la scuola si lanciavano palle di fango – perché la neve non l’avevano mai vista in vita loro; niente. Finché non smise del tutto di affacciarsi e di sperare. Era vecchia, la vita di fabbrica le aveva piegato in due la schiena e la volontà, riducendo la sua esistenza a qualche ora davanti alla tv, sonno incerto e difficile, pasti frugali e monotoni, solitudine e tristezza.
La mattina del 20 giugno 2080 la sirena della fabbrica non squarciò il silenzio dell’alba. Nessuna fila di uomini in uscita, nessun passo cadenzato e lento in entrata. I telegiornali annunciarono che un gruppo di poeti dissidenti, organizzato in cellule segrete, aveva manomesso l’impianto della POIESIS, distruggendo le idrovore e squartando le ruote dei furgoni di raccolta materiali letterari. Dai tetti della fabbrica furono lanciati mucchi di volantini: poesie, aforismi, terzine dantesche, liriche antiche e moderne, stralci di romanzi, racconti, lettere d’amore. Sul retro di ciascuno uno strano simbolo: un ciocco di legno contorto e sgraziato con le radici piantate tra le nuvole e la chioma, zeppa di frutti, che pendeva come un lampadario. Quella mattina, Luigina non si svegliò. Il sonno che faticava a mantenere l’aveva completamente soggiogata; dormiva profondamente, con un sorriso divertito sulle labbra che sapevano di sale.